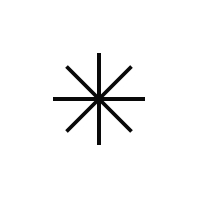Rivelazione
di Elio Mercuri
Poche volte ci è dato sentire una ricerca come risposta ad un dovere, inevitabile, dominata dal senso della “necessità dei greci”; segno di un destino come di fronte al lavoro di Ornella de Cataldo. Dominata dalla forza dei fati, senz’altra possibilità né di fuga né di scelta, in viaggio; nel viaggio da compiere senza certezze di approdi, privo di oracoli.
Da compiere e basta, attraverso la “spoliazione di ogni condizione” in un restringersi sempre più dello spazio consueto per perdersi in una dimensione sconosciuta eppure luogo di vera identità, la de Cataldo ha rapidamente superato, si è liberata di ogni richiamo suadente, di ogni conforto d’illusione di ogni ausilio di ragione e di cultura, nell’accettazione di un impulso, di un gesto che progressivamente scarnificava, le “scarniture dolorose” già avvertite da Virgilio Guzzi che ebbe a seguirla nel suo lavoro di pittrice dalle origini – a metà degli anni 50 quando veniva dalle lezioni di Toti Scialoia – ma come chiusa in un’esperienza che la sospingeva a maturare altre dimensioni della ricerca in alcuni grandi maestri di questo secolo, Nolde, soprattutto Sironi e Picasso nell’attrazione verso una forza di pittura capace di incarnare di immaginare la tragedia e la grandezza dell’umano, del “troppo umano”.
“Il sole nero“, “La morte dell’ariete“, la presenza nella sua grandezza assoluta di “maternità” la de Cataldo sente la voce che la guida da dentro non guarda verso l’esterno presa in questa sfida suprema insormontabile contro la balena bianca che insegue in quell’abisso insondabile che non è l’Oceano, il Mare, ma il Mare metafora che ci abita da sempre nel suo annuncio di tempesta, di apparizioni stregate, ridotti in una spiaggia irriconoscibile dove la linea del cielo e del mare quasi si confondono e noi corpo dobbiamo farci pietra, di pietra per restare immobili ai flutti delle onde e al flusso dei venti. Lasciati là, da un immemorabile naufragio – nel quale abbiamo perduto tutti i beni nudi – fatti terra e pietra – ma in questa estrema condizione, assoluti ed eterni; non più nel gioco della vita e della morte. Il naufragio ci ha privati di molto di tutto ciò che il tempo e la storia aveva sedimentato sull’immagine dell’anima e ci aveva fatto perdere l’esistenza dell’essere per un’infinità di ruoli.
Tutto deve ricominciare.
Sente la verità di uno dei primi “ossi di seppia” di Montale, “Non rifugiarti nell’ombra – di quel folto di verzura – come il falchetto che strapiomba fulmineo nella calura…”. Deve varcare il limite delle nebbie, – la nebbia di sempre – lasciarsi dietro il naufragio che ci ha tolto tutto: l’istinto scenografico, i paesaggi cari, le immagini che non ci consentono di essere. Deve far conto della parte che riesce a sopravvivere ai miti e ai riti, alle abitudini, alle regole, quella “critica” smascherante della “vanità’, della vanità femminile, pesata nei suoi gesti, allo specchio, mentre si pettina per ritrovare la verità, questa presenza assoluta della “maternità” come richiamo a un vincolo assoluto, di sangue e di grembo, di “ammios”, di mistero di vita di dar vita e di morte.
La pittura si fa scarna, tutti i “particolari” si annullano, la lampada e lo specchio, la ciotola e la sedia; i corpi scultorei che si staccano da una nicchia di roccia, ancora colore scuro di terra, intrisi di ombra: grandi in uno spazio che si restringe eppure con una loro potenza di moto – che dilata a grotta, grembo, cielo – luogo immagine nel quale convengono e si fanno carne oltre la differenza e le contraddizioni – l’unità e la sostanza del cosmo.
La de Cataldo ha espresso in modo convincente lo stato dell’uomo contemporaneo; questo suo dramma, il vivere disperatamente in bilico tra l’essere e l’apparenza, tanto da non riuscire più a sentirsi persona, anima, nell’insopportabile leggerezza”. Nella sua ricerca di pittura traduce in immagini questa condizione: il disagio di un mondo visibile, che pure non riesce più a far parte e rivelazione, della totalità dell’essere da ritrovare nelle trame perdute. E allora siamo prigionieri della notte. Vasi della morte.
Quello che vediamo, qualunque sia il luogo si dilegua, tende a porsi in una distanza incolmabile – quasi possibile soltanto – “La famiglia” in un mondo perduto di natura, “Le scimmie” che gli animali ancora sono e che per noi è reale – De Sade – soltanto come “animalità”, quell’animalità rimossa e che ci visita come incubo. Incolmabili di solitudini e di assenze. Per vederlo dobbiamo rinunciare a identificarlo con l’esterno, dobbiamo ricomporlo nei suoi fondamenti originari, nel- l’emozione che valica i confini della ragione; lasciarlo affiorare segno e colore, che non appartiene al sole; ma da noi sepolta dentro e che soltanto la necessità estrema di ristabilire un contatto. Lo sguardo è porta. Porta del visibile, che deve essere visibile per dare accesso all’invisibile. È il segreto di queste figure di donne – ma forse è più giusto figure che precedono la differenza – nell’unità del grembo; emerse da fondali marini inesplorati –“ l sogno di Atlantide” – ancora incrostate di sabbia e di polvere di madreperla odorose di vegetazioni senza nome, di magici effluvi, statue riportate a terra da antichi naufragi simulacri di Dee perdute, scolpite sulle pareti di una roccia come nella città di Petra o in una preistoria lontana di epoche interminabili di creazione (“Le cortigiane”).
Eppure con un bagliore di sangue, con un colore, vive in questo loro porsi non come testimoni di un tempo ma come figure di esistenza, come esistenza dell’essere. La pittura non può vivere in pace con lo spirito del nostro tempo: se vuole ancora scoprire ciò che non è scoperto, se vuole ancora progredire in quanto pittura, non può farlo che contro il “progresso del mondo”. È la ragione della rinuncia che domina la ricerca della de Cataldo; rinuncia all’appartenenza ad una poetica pure così avida di esperienze visive, i suoi viaggi che hanno esteso il suo sguardo a continenti e popoli, di pellegrina per il mondo, la passione per l’arte – i musei, i libri divorati con un’avidità appassionata e profonda – eppure il suo sguardo “quello che vede” non guarda l’esterno.
Quasi questa esperienza straordinaria e intensa pare non aver lasciato tracce se non di corrispondenze, di simmetrie, di illuminazione che soltanto un proprio intimo immaginario ha tramato in tela, intessuta di segni, di strappi, di assenze, evocazione di un universo che valica i confini della geografia, i tempi della storia, gli ambiti della propria quotidianità, la famiglia, gli amici, i luoghi, e invade occupa senza scampo, ogni spazio, ogni ricordo nella memoria che dilaga di origine assoluta e invalicabile.
Sentiamo come la biografia ha incarnato vicende comuni, ha trasformato la storia in storia naturale e tra questi quadri nati da solitudine sentiamo scorrere anche la nostra storia e non soltanto l’esistenza di una donna.
Fascinosi simulacri fantastici e simbolici assumono la presenza dei suoi quadri, la perentoria invalicabile forza di verità rivelazione di valori.
Le immagini della de Cataldo si fanno sempre più essenziali in una loro primordialità che rinvia ai tempi della creazione quasi a ritrovare la purezza della necessità, l’identità come condizione naturale assoluta e respirata nell’aria, sentire non più insostenibile la leggerezza dell’essere nelle forme quotidiane del vissuto.
I graffiti sulle pareti di una roccia – “I geroglifici” – segni sacri dei fondali marini o tracciati dal volo di una colomba – diventano linee di un sogno che annuncia e rende vera la libertà. “Giove” – “Toro” – “II ratto di Europa” – il mito attraverso il quale toccare con gli sguardi il divino, come se fosse una realtà fisica, come facciamo nel nostro mondo quando tocchiamo qualcosa, abita la pittura della de Cataldo nella sofferta sensazione del paradosso che l’ironia vela, perché il divino è proprio quanto si sottrae allo sguardo, il nascosto, l’occultato, l’incomprensibile e irriducibile enigma, il santuario al quale nemmeno gli uccelli possono avvicinarsi. Le sfingi davanti ai templi ci annunciano questo destino di oscurità: “Io sono tutto ciò che è stato e che sarà e nessun mortale sollevò mai il mio peplo”.
La de Cataldo diffida di chi trascrive il mito in segni naturali, “in venti e corsi d’acqua, semine e arature e accidenti della terra e passaggi di stagione”. Vuole pensare miticamente, raggiungere il luogo che nessun viaggio per terra o per mare può portare a scoprire dove il contrasto tra il principio dualistico e l’armonia degli opposti si scioglie in ritmo diviene figura, “immagine dell’anima”.
Figure, perché una “reverie” non sia semplicemente la vacanza di un’ora fuggitiva; occorre che trovi la sua materia, occorre che un elemento materiale le dia la sua propria sostanza perché non più metafora e simbolo torni vissuto.
Dalla rappresentazione “esterna” dall’apparenza delle cose la tensione, spinge a ristabilire l’ordine, l’armonia del cosmo dei pianeti anche nel respiro del corpo, nel flusso del sangue, nelle relazioni e le corrispondenze dei giorni, e quel che più conta nelle opere.
Può così operare figurazioni che ricongiungono la pittura ad una sua arcaica potenza scultorea con l’esito di dar forma a nuove e inaudite dimensioni, ad una spazialità diversa dalla visione prospettica. Gli elementi materici animati da un’ancestrale memoria lirica uscita dal labirinto di antichi tormenti elabora in questo “campo” di attrazioni magnetiche che fanno immanente all’immagine l’armonia del cosmo. Le opere sono atmosfere atemporali sostanziate di luce e costruite da un’unica linea nitida e netta, soffice e ironica come un divertimento mozartiano che nel suo procedere ingloba spazi e accenna a probabili, preistorici modelli umani.
Si forma l’immagine liberamente, svincolata da ogni senso, attraverso la linea che crea spazi nella dimensione assoluta di una luce iniziale precedente ai colori della creazione. Vere trasmutazioni della materia per rifrangere l’essenza, cioè la qualità di un mondo o riginale per tutti l’archetipo della madre da ricondurre alla superficie, come gli altri, dimenticati, custode di miti, di simboli e di memoria da trasmettere nel viaggio – che ancora un volta – è ritorno.
La pittura è la chiave nel suo rapporto con la realtà che sempre è mediato da filtri evocativi, allo stesso tempo fantastici e autobiografici. Il gioco della memoria profondamente turbata trova eco tormentosa, alle pulsioni espressive, esperienza impareggiabile delle forme è l’insieme della vita. La de Cataldo ha saputo con calda e intensa emozione rendere in immagine il maturare dell’anima e l’usura della vita fino a sperimentare, sulla carne l’esistenza il destino predetto per ognuno dall’inno a Zeus nell’Agamennone di Eschilo: solo il dolore può condurci alla coscienza e alla saggezza. Non a caso per millenni le rappresentazioni antropomorfe saranno esclusivamente femminili. Siamo al termine del viaggio – prossimi al luogo dove il ritorno si compie.
Dalla biografia come esito di una storia di una vita a toccare con gli occhi il divino – prossimi alla presenza dell’archetipo
Tutto è trasfigurato in questa condizione – anche il recupero di un tempo non vissuto di felicità. Questi corpi – che al di là della linea si trovano dopo il buio divorante, di fondi di luce livida, scuri di luce infeltrita di immemorabili colori nello stato di rischio, nel farsi ogni gesto spazio di vuoto nel quale si scatenano figure di tragedie o di silenzio – e scoprono la magia del volo, la leggerezza del gioco, l’altalena, la movenza di misteriose danze, soprattutto la condizione della musica, armonia cosmica liberata nella dimensione di se; non più viscere per una notte e corpo alla violenza inaudita. È la prova di una ricerca che spesso è lotta segreta, ricerca sofferta senza meta da raggiungere, risposta ad una sfida lacerante quanto indefinita nell’origine e nello scopo, l’oppressione di una condizione che non lasciava respiro, se non quella di un ruolo di vanità. “La donna allo specchio” “Al bagno” immobile nei gesti consegnati al nulla. Immagini di ciò che era concesso e l’ironia tagliente, spaesata di non poter stare in quei panni, in quegli interni tra quelle cose, cosa.
Ha dovuto perdersi al mondo, al possesso, per ritrovarsi “anima” vivere così in sé, un’esistenza di donna e allora non potevano essere che dramma nel quale si compie il destino di vita. C’è la malinconia profonda di ogni rinuncia, la perdita di un ritrovamento che è riconoscimento di sé, a quel punto in un frammento soltanto in lembi di inenarrabile ferita di un’individuazione che è legge di Antigone.
Vedere e credere: “invoco le rimembranze delle cose perdute” (Shakespeare, sonetto XXX). Borghese…
“Sono altri modi” di indicare l’anima caduta esiliata nel mondo della fattualità. Finché l’anima resta in esilio, noi vediamo le cose solo con gli occhi dell’esule, ricordiamo Il passato solo nella sua fattualità, immaginiamo il modo per uscirne solo come sviluppo progressivo. Ma non si ha sviluppo nell’esilio. Non può, non si può ricostruire in immagine il passato, il luogo, la casa; nessuna “Itaca” può segnare la fine del viaggio nessuno dei Mondi conosciuti.
È “necessità” ricostruire il tempio che reintegra la città, l’ordine della società, le relazioni quotidiane alla rimembranza della sua anima.
Si diventa quel che si è, il solo modello che rimane è l’evento e le sue immagini che guidano il comportamento nell’evento stesso, si ritrova il proprio nome, avendo solo l’essere ciò che si è, un essere che possiede le immagini.
Essere nell’anima è la sola armonia concessa – e la pittura si trasforma da viaggio a iniziazione, con la perdita del modello e del potere – si frantumano le icone delle rimembranze per varcare la soglia delle forme, figure dell’essere. Lo spazio si restringe — quello esterno, limitato e inabitabile della “scena” – “Il lupo è morto“; quel lupo che evoca il terrificante di ogni aggressività; l’animalità chiusa in sé stessa; la cupa violenza di un gesto in cui è chiuso il segreto della vita che nessun oracolo mai potrà svelare, più della musica dell’anima che muove leggere le dita “sulle corde dell’arpa” o gonfia senza paura la paura di Athena le gote nel modulare il suono del flauto.
Non è più sfida la sfida di Marsia che conduce a morte, è l’incarnazione del ritmo in forma, immagine che prende corpo e sostanza di vita, della vita.
La liberazione è condizione ora di libertà.
La liberazione dal passato, dalle convenzioni e dalle cose dai ruoli per ritrovarsi sentimenti. L’amore mancato, il gioco mancato, ogni mancanza è immagine di desiderio che si ricompone in un equilibrio che non è più memoria – segno dell’esilio – ma finalmente immagine dell’anima, impronta di amore.
I quadri ultimi della de Cataldo, prossimi a nuovi approdi, ci conducono a guardare in quella grande notte impenetrata e sconfortante della nostra anima che confondiamo con il vuoto e con il nulla per scoprirvi l’anelito umano all’eterno e all’assoluto.
L’esistenza torna sulla nascita anziché sulla morte, sul venire al mondo anziché ritornare all’eterno. Prevale la priorità della madre e il tempo della vita.
Il ritmo, respiro libero in figurazioni di musica, armonia – in questo ciclo.
Da “La famiglia”, “Memoria d’America”, “La donna col pesce rosso” scopre la magia del volo, la leggerezza del gioco, “L’altalena“, “La danza“, soprattutto la condizione della musica in una liberata e ritrovata dimensione.
Dal catalogo “O. de Cataldo, Dipinti – dal 1970 al 1983”
,