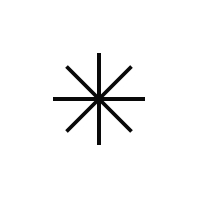Attraverso le antiche immagini
di Elio Mercuri
Nei confronti di questa presenza esterna l’artista ha avvertito come il senso di un’oppressione – questi spazi che si restringono, gremiti di “cose”, in un arredo ossessivo ingombrante che non lascia entrare la luce del sole. Il colore infeltrisce, si fa brumoso e denso, l’aria si oscura e il gesto più semplice – “La donna allo specchio” – “La donna che cuoce il pesce rosso” – si trasforma e si trasmuta in situazione di tragedia congelata, che soltanto un lampo ironico può allontanare e nel distacco porre argine alla ossessiva aggressività.
Pur nella sua costruzione, nella vera significanza di ogni oggetto, nell’apparente aderenza di ogni cosa avvertiamo il malessere di una visione che “spaesa” non nel senso di Magritte o del surrealismo, che occupa la realtà esterna con la dimensione del profondo dove il vero contatto si realizza con esiti che stravolgono il senso ordinario – né dell’esasperazione espressionistica dalla quale pure mutua nella prospettiva da Sironi a Bacon l’emozione più intensa – ma in questa sua “fissità” anche nel gesto che tende disperatamente a ritrovare la dimensione primordiale, archetipale, per la quale ogni presenza cosmica comunica con il linguaggio dell’anima.
Lo spazio oscurato – chiuso nel quale si consuma il dramma di “Casa di bambola”; quelle pareti che pure erano spazio che poneva un alt, al rischio di una disperazione e corruzione finale; quelle stanze di “Casa di bambola” che si ergevano come blocco dell’incontenibile slancio, impulso, energia che pure come linfa sotterranea cercava come propria individuazione, in questo rovesciamento di prospettive, si fanno non più muro ma nicchia, caverna, grembo da cui prendono carne e sangue, intimità – “La doccia” – nel ricongiungimento a quel mistero che avvolge la vita e la morte.
Non più la ricerca di ritrovare in un’assoluta legge di natura, – “La famiglia” – “In gabbia” – nell’animalità uno stato di verità, una condizione estrema nella quale è ancora intero il “valore” dell’esistenza, in queste presenze che restituiscono l’immagine autentica della vita, metafore di disperazione e apparizioni di sogno; “Gli animali del sogno” di Hillman, invocazione di poter conoscere in tutta la totalità e non ombre – in quell’ombra che la luce oscurata sempre più diventa parte interna che costruisce la figura o forse è più preciso dire “la sembianza” – questo tentare di evadere dall’abbraccio di “ombre” di un improbabile viaggio nell’aldilà, nella crisi di ogni attesa di avventura del mondo – per ritrovarsi qualcosa da “toccare” da stringere nostro.
È il bisogno della scultura – questo suo dar corpo all’immagine sentirla in una sua realtà di forma, liberazione dalla paura che tutte quelle immagini siano presenze di sogno – che non riscaldano e non danno senso ai giorni (“Nudo disteso”). Dopo aver sfiorato l’informale, il tormento dell’irruzione dell’inconscio con toni che richiamano il Vacchi del “Dopomondo” quella serie tragica di ritratti che pure riscattano il volto di Pasifae – in un cielo di straordinaria intensità e maturazione di un proprio “discorso” originale e autonomo nella trama di simmetrie con momenti essenziali della ricerca dell’arte moderna – non solo moderna – nel suo ritrovare la dimensione dell’Archetipo.
Il segno che era stato corroso dall’ombra – riemerso nel magma materico per differenziazione in quella tensione e trasmutare la materialità in colore-luce ha ritrovato la dimensione di filo che dipana la matassa e tesse la trama-segmento di linea infinita che in una dimensione atemporale sottratta alla categoria dello spazio s’inscrive punto e figura dell’Essere in un’atmosfera cosmica punto su un diametro cosmico nel campo di questa attrazione magnetica che libera da ogni peso il corpo e gli restituisce l’anima. Levitano a passo di danza, in gesto di gioco, in colloquio di uomo-animale, si dilatano a cielo nell’essenzialità, estrema del ritrovamento-equilibri che sottendono l’armonia.
L’immagine può così finalmente dare comunicabilità all’anima, oltre ogni separazione e differenza nell’identità ormai raggiunta.
Dal catalogo “O. de Cataldo, Dipinti – dal 1970 al 1983”